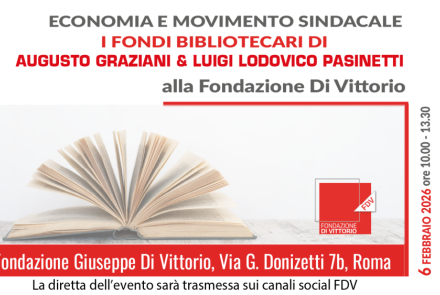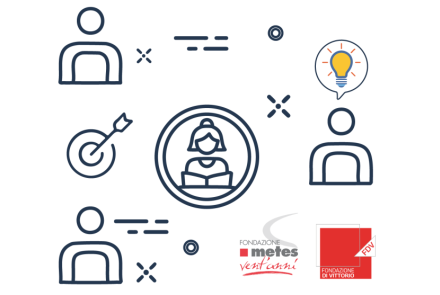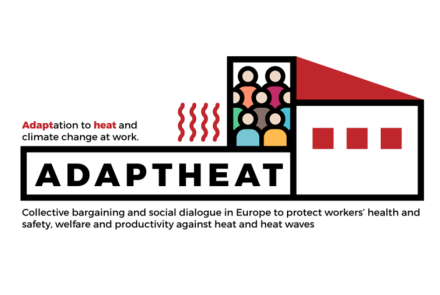DUE MUSICISTI, UNO SPARTITO: LA DIALETTICA TRA CGIL E PCI NEL NOVECENTO ITALIANO
In una fase come quella attuale, in cui viene ampliandosi non solo la distanza tra cittadini e istituzioni, ma anche quella tra i primi e i corpi intermedi (si parla sempre più, non a caso, di “disintermediazione”) appare indispensabile tornare a ragionare delle forme in cui si articola la relazione tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale. Volendo farlo in prospettiva storica, un punto di vista particolarmente fertile può essere individuato nel rapporto tra i sindacati confederali italiani e i rispettivi partiti di riferimento. La prima tappa di questo “programma di ricerca” può essere rappresentato dalla ricostruzione del rapporto intercorrente tra il Partito Comunista Italiano e la CGIL: caso di studio stimolante e interessante per via delle dinamiche che hanno contraddistinto questa relazione, fatta di intrecci ma anche di frizioni.
Per circa mezzo secolo i dirigenti e gli iscritti a queste due organizzazioni della rappresentanza politica e sociale dei lavoratori si sono infatti sentiti parte di una storia comune, ideologicamente ampiamente condivisa che partiva dalla stessa premessa e tendeva allo stesso fine. Ciononostante affrontarono la lunga traversata del Novecento con le proprie specificità come due musicisti che interpretavano diversamente lo stesso spartito. Anche e soprattutto perché, in questa variazione di toni, non avvertivano nessuna contraddizione. Le due rappresentanze esprimevano esigenze diverse: il partito poteva raffigurare una forma ideologica più compiuta e ancorata a un sistema filosofico coerente, doveva esprimere una sintesi politica onnicomprensiva, guardando al quadro complessivo della rappresentanza. Il sindacato, dal canto suo, aveva, invece, la necessità di tenere insieme la prospettiva ideologica con il confronto quotidiano con i lavoratori, con i loro problemi, le loro esigenze, il loro grado di soddisfazione o critica che non di rado entrava direttamente nelle forme dell’organizzazione. Se la storia era il “Tribunale del partito”, i lavoratori erano e sono il “tribunale quotidiano del sindacato”.
La cultura comunista aveva sviluppato una concezione propria del rapporto tra rappresentanza politica e sindacale. Per i comunisti, il partito era l'avanguardia rivoluzionaria del proletariato, la struttura depositaria dell’interpretazione scientifica dello sviluppo storico, la massima espressione della coscienza di classe. Se il partito era insomma lo strumento attraverso cui la classe avrebbe superato i limiti resistenziali e rivendicativi della propria azione, tutte le strutture collaterali si sarebbero dovute adeguare al suo ruolo direttivo: la famosa teoria della cinghia di trasmissione.
Eppure, anche durante i periodi di maggiore convergenza con la leadership comunista, la CGIL è sempre rimasta una organizzazione con ampi margini di autonoma, interprete di una storia nella quale quella comunista rappresentavano solo una delle culture presenti (anche se a lungo quella dominante e più influente). Una organizzazione che è stata capace di sopravvivere alla fine del PCI a testimonianza di radici e identità che, pur nutrendosi a lungo degli stessi valori, non si esauriva in quella storia.
Da dove nasceva dunque questa aporia tra teoria e pratica? Dove le ragioni di un rapporto molto più complesso di quanto la semplice applicazione della teoria della cinghia di trasmissione lascerebbe supporre? Il libro, che dal punto di vista cronologico parte dagli anni del primo dopoguerra per concludersi con l’esaurimento dell'esperienza storica dei socialismi reali (e le contestuali trasformazioni di CGIL e PCI), si concentra su tre temi per indicare una possibile risposta: l'originalità del modello sindacale italiano; la ricchezza del dibattito politico del mondo comunista; il peso dei vincoli internazionali, ideologici, culturali. A chiudere il ragionamento, i ritratti dei due personaggi che meglio incarnano l’idea degli “eretici della Cgil”: Giuseppe Di Vittorio e Bruno Trentin, i due “comunisti irregolari” maggiormente rappresentativi della complessa dialettica esposta sopra.