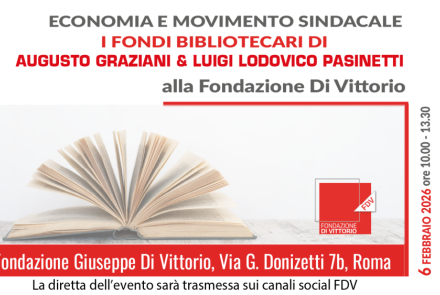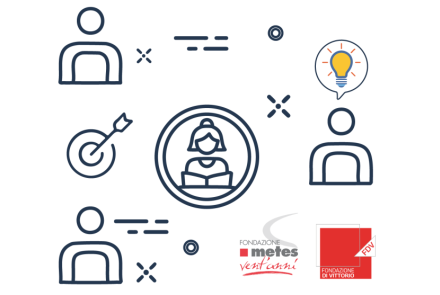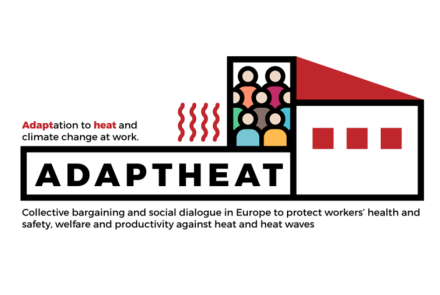Papa Francesco, la sua morte, il mondo e noi
Con la morte di papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo, si chiude, almeno per ora, la lunga scia di pontefici non italiani, avviata nel 1978 con l’elezione di papa Giovanni Paolo Secondo, polacco, al quale fece seguito, nel 2005, l’elezione di papa Benedetto XVI, tedesco, il quale, com’è noto, si ritirò dal soglio pontificio nel 2013. Per capire l’evoluzione della Chiesa nei confronti del mondo moderno, e per comprendere i tanti aspetti del pontificato di papa Francesco, il papa venuto dall’Argentina, bisognerebbe partire da una rilettura, perfino coraggiosa dal punto di vista teologico, di questo mezzo secolo. Ciascuno dei tre pontefici non italiani ha cercato di imprimere a sé stesso e alla intera Chiesa quel messaggio evangelico (soprattutto nel testo di Giovanni) per il quale occorre sempre essere “segno di contraddizione” in un mondo che si evolve distruggendo l’umanità. E a modo loro, qualunque ne sia il giudizio di ciascuno, Giovanni Paolo Secondo, Benedetto XVI e Francesco si sono trovati in questa condizione storica e politica nella quale l’adeguamento alle storture della modernità e l’adagiarsi nella prospettiva del privilegio e della ricchezza di pochi avrebbero di certo manifestato il più grande dei timori nella Chiesa contemporanea, l’omologazione in un mondo che non ha mai smesso di produrre armi e guerre (perfino nel cuore dell’Europa), e di finire stritolata nell’epoca della devastazione disumana.
Essere “segno di contraddizione”, nella prospettiva teologica, assegnava a ciascuno di questi tre pontefici la missione di interpretare la Chiesa nel mondo contemporaneo con le sue sfide, offrendo soluzioni concrete ai suoi mali interni ed esterni, richiamando il valore universale della dignità dell’uomo, per sempre e ovunque, recuperando la dialettica tra fede e ragione, rispondendo alla secolarizzazione e ai conflitti, armati e non, con il dialogo e non con la paura o l’imposizione di una tesi religiosa. Papa Francesco, fin dall’inizio del suo pontificato, ha raccolto le sfide che i suoi due predecessori avevano provato a contrastare nel corso del loro pontificato. E lo ha fatto a modo suo, con tanta originalità, ma senza mai dimenticare la missione di essere “segno di contraddizione”, affidata al pastore, primus inter pares, chiamato a guidare il gregge dei cattolici, e non solo.
Ecco perché papa Francesco, già nel luglio del 2013, pochi mesi dopo l’elezione, compie il suo primo viaggio a Lampedusa, dove condanna “la globalizzazione dell’indifferenza”, che è già un giudizio assai severo sul mondo occidentale egoista e chiuso, che non accoglie e lascia che sia la morte nel “cimitero mediterraneo” a dare soluzione alla questione migratoria. E sono segni di contraddizione sia la prima enciclica, molto “francescana” perfino nel titolo, Laudato si’, nella quale l’indifferenza globalizzata al creato diventa un pericolo per la sopravvivenza della vita sul pianeta ed è causa delle migrazioni imponenti, sia l’indizione del Giubileo della Misericordia, dove l’attenzione all’uomo moderno si focalizza sulle sue fragilità, sullo smarrimento collettivo, sulla sofferenza arrecata e mai perdonata (ed è all’origine della istituzione carceraria, che molto spesso elimina dignità e valore all’umanità di chi è costretto a viverla, che sia condannato o che sia agente di polizia). E come non rammentare l’altro “segno di contraddizione”: quelle immagini del marzo del 2020, quando, in piena pandemia da Covid-19 e l’umanità sembrava avvolta dalla disperazione, papa Francesco, sotto la pioggia battente, disse messa da solo in una piazza San Pietro tragicamente vuota. Egli sperava in un cambiamento di orizzonti e di prospettive dopo la pandemia, sperava in un’umanità che avesse imparato a essere più solidale e cooperativa, sperava che la via d’uscita dalla disperazione collettiva che in quel momento agitava il mondo intero fosse proprio quella svolta “antropologica”, per così dire, per la quale il senso delle vite, o meglio di ogni vita, di ogni “mondo della vita”, fosse l’aver ritrovato lo spirito comunitario dell’aiuto reciproco.
Papa Francesco dovette ricredersi, perché quella “guerra mondiale a pezzi” non dava cenno di finire. Anzi, poco dopo, quei conflitti si fecero ancora più cruenti, sempre più la barbarie dominò segmenti del pianeta, dall’Ucraina alla Palestina al Sud Est asiatico alle regioni dell’Africa. Papa Francesco si scoprì solo nel sottolineare la necessità di dare un giudizio fortemente critico contro il paradigma tecnocratico che uccide l’umanità a beneficio del profitto (come, ad esempio, sottolinea il presidente di Pax Christi), di porre fine ad ogni conflitto armato mediante il dialogo dei popoli e delle diplomazie, e alla produzione di armi. Lo ha fatto perfino nella sua ultima orazione nel giorno di Pasqua del 2025. E non è per caso che l’atto finale del suo pontificato sia quel documento importantissimo di indizione del Giubileo 2025, “la speranza non tradisce, spes non confundit”.
Oggi, con la morte di papa Francesco, che tanto dolore ha provocato in miliardi di persone nel mondo, si apre una nuova fase, non solo per la Chiesa cattolica, ma per tutti noi. La sua lezione rimarrà esemplare per chiunque, credente o non credente. E forse “essere segno di contraddizione” sarà una missione talmente scolpita nella mente e nella memoria dei cardinali, da indurci a essere ottimisti per il futuro.
foto: Marco Merlini