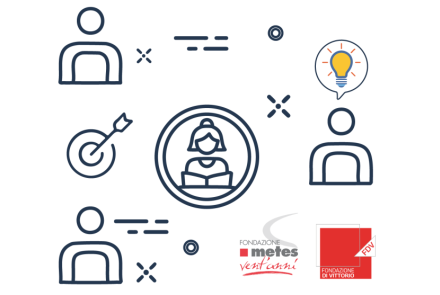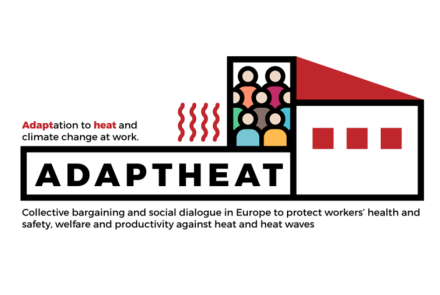Nel nome del padre, di Alessandro Casellato
Il saggio che segue è apparso sull'ultimo numero di Belfagor (http://www.olschki.it/riviste/belfagor.htm)
Il 13 settembre 2002 Bruno Trentin viene insignito della laurea ad honorem in Economia e commercio dall’università Ca’ Foscari. Si trova a pronunciare la sua lectio doctoralis nell’aula magna che porta il nome di suo padre. Non può evitare di riferirsi a lui, con poche ma impegnative parole.
Sono stato sempre restio a parlare di lui pubblicamente, per il rispetto e la riconoscenza che gli debbo. E non cambierò oggi il mio atteggiamento. Voglio soltanto testimoniare che quel poco di valido e di utile che ho saputo produrre nel corso della mia lunga vita, lo debbo interamente al suo insegnamento e al suo esempio; alla sua radicale incapacità di separare l’etica della politica dalla propria morale quotidiana, pagando sempre di persona per i propri convincimenti.
Silvio Trentin aveva lasciato la cattedra di Diritto amministrativo a Ca’ Foscari nel 1926, in opposizione al fascismo che si era fatto regime. Aveva consegnato le sue dimissioni e si era trasferito in Francia con la moglie, Beppa Nardari, e i due figli ancora piccoli, Giorgio e Francesca. Dieci mesi dopo in Guascogna, nel paesino di Pavie, gli era nato il terzo figlio, che registrò all’anagrafe col nome di Bruno Libero Vittorio. Risultò una complicazione imprevista più che un segno benevolo del destino. I soldi, molti, si esaurirono dopo due anni in un’impresa andata male; nel 1928 Silvio Trentin fu costretto a trovar lavoro come operaio tipografo, nella città di Auch. La riconversione dell’ex proprietario terriero e deputato del Regno prima all’esilio e poi al lavoro manuale aveva avuto pesanti ripercussioni sul tenore di vita e sui rapporti familiari. Nei ricordi del figlio, Silvio Trentin era «un uomo che si condannava ogni giorno a lavorare in una tipografia prima e in una libreria poi, continuando la notte a scrivere e a studiare fino alle ore piccole del mattino». L’esempio morale e politico che Bruno avrebbe riconosciuto a suo padre a distanza di settant’anni aveva significato, quand’era bambino, una vita assai poco agiata. Il rigore di quell’uomo confinava pericolosamente – agli occhi degli stessi familiari rimasti in Italia – con la testardaggine di un pazzo che aveva messo a repentaglio una posizione, un patrimonio e il benessere suo, della moglie e dei figli per una fissazione senza speranza.
Per il giovane Bruno il padre era una figura allo stesso tempo distante e incombente. Troppo fascinoso per non farsene irretire, specie nei rari ma appassionanti momenti che dedicava a lui portandoselo dietro in lunghe passeggiate in campagna. Ma anche troppo impegnato altrove con la testa e con il cuore per non sentirsene privato. Era un modello irraggiungibile. Un padre «tutto d’un pezzo», severo ed esigente. Il ragazzino cercò la propria strada fuori di casa, talvolta letteralmente scappando per le colline. Nella piazza di Auch aveva trovato un altro monumento, immenso, da cui lasciarsi affascinare: D’Artagnan e i moschettieri avevano riempito la sua infanzia; ne aveva rivissuto le avventure nei rapporti coi coetanei, in giochi di bande giovanili spericolati, rissosi, anche violenti, ai confini con la delinquenza di strada. Cercava lo scontro fisico. E si sentiva sempre più francese quanto più vedeva suo padre guardare continuamente all’Italia, incontrarsi con amici italiani, rubargli altro tempo con la politica.
Nel 1934 alcuni parenti e amici vicini a Giustizia e Libertà procurarono a Silvio Trentin una libreria e una casa a Tolosa; il negozio e l’abitazione divennero luoghi di incontro tra gli esuli italiani e poi, dal 1936, centri di smistamento per i volontari diretti in Spagna. La vittoria del Fronte popolare e il governo di Léon Blum in Francia avevano dato nuovi spazi di manovra a Trentin e agli antifascisti. Bruno conobbe una faccia meno cupa della politica, finalmente piena di speranze, nei volti dei volontari antifranchisti ai quali cedeva il letto e che in cambio gli raccontavano le loro vite da romanzo, e su quelli degli operai nelle piazze che reclamavano le ferie pagate e la settimana lavorativa di quaranta ore. Ebbe un precocissimo apprendistato alla vita pubblica, al dibattito delle idee: ancora bambino poté ascoltare Emilio Lussu e Carlo Rosselli; qualche anno dopo conobbe Giorgio Amendola – venuto da suo padre a siglare il patto per l’unità d’azione tra i partiti antifascisti – allacciando così, ancor giovanetto, un rapporto con l’uomo che sarebbe diventato nei decenni successivi il suo principale antagonista all’interno del Pci.
In politica il suo primo amore fu per l’anarchia: Kropotkin su tutti. Cercava un terreno di confronto e di conflitto con il padre, che dal liberalismo da cui era partito si stava spostando sempre più a sinistra. Ma gli anarchici li incontrò anche di persona, nel momento in cui furono costretti a scappare dalla Spagna, dopo la sconfitta della Repubblica, e a trovar precario rifugio in Francia. Ebbe da loro le notizie della repressione che avevano condotto i comunisti a Barcellona: una guerra civile dentro una guerra civile.
Di queste cose sappiamo i particolari e i significati – che sono il sale in una biografia – quasi esclusivamente dalle testimonianze orali che Bruno Trentin ne ha dato a distanza di molti decenni. Li traguardiamo, quindi, attraverso tutti i filtri che una vita assai densa ha accumulato nella sua memoria. Quanto nel ricordo che Trentin ha della guerra di Spagna – o, come vedremo, della Resistenza – c’è di quel che visse, pensò e rielaborò negli anni sessanta, nell’“autunno caldo” o nella stagione dei consigli di fabbrica? Quanto nell’immagine degli anarchici di allora c’è di quella degli “estremisti” variamente declinati che avrebbe incontrato tanti decenni più tardi? E fino a che punto, viceversa, su questi ultimi si sarebbero proiettati i fantasmi della sua memoria di ragazzo? Dove si è smarrito, infine, il suo ricordo della prima fase della guerra, quando i comunisti diventarono improvvisamente dei nemici a seguito del patto russo-tedesco, e l’Italia invase la Francia, complicando vieppiù il viluppo delle appartenenze nazionali e politiche in casa Trentin?
Pur con tutte le cautele, è però difficile sfuggire all’impressione che proprio nel confronto/conflitto con il padre e nell’apprendistato alla politica, negli anni della sua giovinezza che coincidono con una fase che si apre con la guerra di Spagna e si chiude con la Resistenza, si depositi nella personalità e nella cultura politica di Bruno Trentin un’impronta che egli si porterà dietro per tutta la vita e che – via via aggiornata, rielaborata, magari anche deformata – interagirà sempre con il suo modo di essere, di interpretare il proprio ruolo, di stare dentro la storia. Sono anni in cui gli schieramenti si mescolano e si ricompongono. Bruno ricorda la brusca rottura di suo padre con Léon Blum, che considerava come un traditore per non essersi schierato chiaramente a favore della Repubblica spagnola, e le affinità, invece, con i radicali d’ogni colore, fossero anarchici, comunisti o cattolici antifascisti come Bernanos. La Spagna imponeva «di scegliere un’altra volta il proprio campo», chiedeva che alle parole e ai programmi seguissero azioni coerenti. Si stabilivano su questo piano, tra uomini di culture diverse, sintonie esistenziali oltre che politiche, che poi transitavano dal padre al figlio, e viceversa. Di qui, ad esempio, la radice della comune avversione per il «riformismo» parlamentare – cioè per l’esperienza storica dei socialisti, sia italiani che francesi, di fronte al fascismo e a Vichy – che finirà per collocare Silvio all’estrema sinistra di Giustizia e libertà e poi del Partito d’azione, e Bruno a scegliere, durante la Repubblica di Vichy, di mettere su, quindicenne, un gruppo insurrezionale per attaccare i cagoulards e successivamente, dopo la parentesi nel Partito d’azione, di guardare al Pci – e non al partito socialista – come campo privilegiato in cui riconoscersi e mettersi in gioco.
Sul terreno della Resistenza padre e figlio trovano un’intesa profonda, affettiva e politica, di pensiero e di azione. Lo si potrebbe chiamare passaggio di testimone, se non si rischiasse di enfatizzarne la consapevolezza. Certo è proprio durante il viaggio clandestino dalla Francia all’Italia nell’agosto del 1943 che Silvio manifesta i primi segni della malattia cardiaca che l’avrebbe portato alla morte sei mesi più tardi. Per Bruno, invece, quel viaggio assai rischioso è una sorta di seconda nascita. Il padre lo ha voluto espressamente con sé, vincendone l’iniziale riluttanza a lasciare la Francia che il giovane sente come propria patria. L’esule fa ritorno nella vecchia casa dei Trentin, a San Donà di Piave, accolto trionfalmente. Due giorni dopo, l’8 settembre scompagina ancora le carte e lo costringe a una nuova clandestinità. Silvio prende contatti con Concetto Marchesi ed Egidio Meneghetti per dar vita subito alla Resistenza armata. In questi mesi è chiara la sua vicinanza ai comunisti, sia dal punto di vista teorico che politico; il Partito d’azione gli sta stretto e gli appare, soprattutto in Veneto, come eccessivamente moderato, ideologicamente confuso, sostanzialmente attendista. Il Diario di guerra di Bruno – dal 22 settembre al 15 novembre 1943 – è scritto con la perentorietà di un ragazzo di sedici anni, ma trasuda umori condivisi col padre: «Bisogna porre fine a questa torbida situazione di compromesso!! Azioni nette e decisive!!!», annota il 1° ottobre, di fronte alle profferte di “conciliazione nazionale” che il nuovo prefetto di Venezia avanza nei confronti degli antifascisti. L’Unione sovietica è un faro che ispira fiducia e diffonde speranza; gli Stati Uniti e l’Inghilterra «due regimi marci e arretrati», espressione di un «mostro capitalista» che sarà stroncato dalla «grande Rivoluzione»: «la lotta antinazista e antifascista», scrive il 4 novembre 1943, «è la prima fase della guerra dei popoli, la lotta anticapitalista ne sarà l’apoteosi e il trionfo definitivo».
Nel gennaio del 1944, mentre è ormai ricoverato all’ospedale di Treviso, Silvio detta al figlio un Abbozzo di un piano tendente a delineare la figura costituzionale dell’Italia al termine della rivoluzione federalista in corso di sviluppo. Questo è forse il vero testimone, che resterà nella testa di Bruno come una bussola per i sessant’anni successivi. Silvio Trentin vi prefigura una Repubblica federale basata sui principi della libertà della persona, della autonomia istituzionale, della proprietà collettiva e della giustizia sociale; disegna uno Stato incardinato nel «regime dei Consigli», che sono espressione di «qualsiasi comunità di lavoro, qualunque sia la natura o l’ispirazione del lavoro, la quale implichi la collaborazione permanente o professionale di almeno cinquanta persone».
Il 12 marzo Silvio muore e Bruno torna in clandestinità. Il padre, prima di andarsene, è riuscito ad affidarlo alle cure di Leo Valiani. Dopo l’estate, passati alcuni mesi nelle formazioni partigiane intorno a Vittorio Veneto, Valiani lo chiama a sé, a Milano, a fare lavoro gappistico. Qui conosce Vittorio Foa, arrivato dal Piemonte. Insieme a lui scrive il proclama dell’insurrezione, insistendo – e ottenendo – che contenga la frase: «la bandiera rossa sventola su Berlino».
La Resistenza a Milano è stata decisiva per fare entrare Bruno Trentin, appena diciottenne, nella cerchia dei dirigenti nazionali del Partito d’azione. Ma è quella condotta nel Veneto ad averlo toccato più in profondità. In città si era trattato della solita, durissima e alienante «clandestinità pura» che aveva conosciuto anche in Francia; invece, la guerra all’aria aperta sulle colline trevigiane, nella lunga estate del ’44 così ricca di speranze, era stata una rivelazione: Bruno aveva vissuto il suo particolare incontro con l’Italia profonda, con le avanguardie contadine e operaie in lotta, e con le masse rurali in attesa, partecipi e diffidenti allo stesso tempo rispetto al movimento partigiano; la “guerra di popolo” era stata un’esperienza conturbante, che l’aveva conquistato a una nuova patria e a una nuova idea di politica, e aveva orientato già allora la sua scelta di rimanere in Italia a guerra conclusa.
Da Di Vittorio al «neocapitalismo»
Dopo la liberazione Bruno Trentin si mise la Resistenza alle spalle. Come Foa, rifiutò di aderire alle associazioni partigiane: non si considerava un reduce, e neppure una vittima del fascismo. A diciannove anni, sentiva di avere il mondo nelle mani: aveva fretta di «divorare conoscenze, luoghi, persone». Rimase nel Partito d’azione, responsabile dei giovani; a Milano lavorò con Riccardo Lombardi al «Giornale di mezzogiorno» durante la campagna elettorale per la Repubblica. Viaggiò molto tra il Veneto, Milano e Roma; conobbe l’Italia. Si iscrisse a Giurisprudenza a Padova, faticando a dare esami a causa dell’italiano ancora stentato. Per un periodo, durante il 1947, fu negli Stati Uniti, ad Harvard, dove incontrò Gaetano Salvemini. A Padova prese a frequentare l’Istituto di filosofia del diritto, cioè Norberto Bobbio ed Enrico Opocher, il futuro relatore della sua tesi di laurea – sulla Corte suprema degli Stati uniti, dal titolo La funzione del giudizio di equità nella crisi giuridica contemporanea – che avrebbe discusso il 16 ottobre 1949. Voto non brillante: 99/110, segno di un percorso di studio accidentato. La ricerca sviluppava alcuni spunti teorici di suo padre sull’edificazione del federalismo dal basso, non per via costituzionale, e li applicava all’esperienza giuridica americana, rivelando un interesse specifico per l’adeguamento del diritto alle trasformazioni della società.
Nel frattempo il Partito d’azione si era sciolto e aveva messo i suoi militanti in libertà. Per Trentin la crisi del ’47 non dovette essere un grosso lutto, ma un’evoluzione fisiologica preventivata e forse attesa. Vittorio Foa ne Il cavallo e la torre ricordò che già nel 1946, dopo la scissione di Parri e La Malfa, Leo Valiani aveva guardato Bruno negli occhi e gli aveva detto: «Tu, tu, andrai nel Partito comunista!». Era stata una profezia non difficile. I suoi fratelli e molti dei suoi amici già ci erano dentro o sulla soglia, e lui stesso aveva maturato una certa predisposizione sin dagli anni della Resistenza e del sodalizio con il padre. Trentin non volle seguire i dirigenti azionisti con cui era più in sintonia – come Foa, Lussu e Lombardi – nel partito socialista. Il Pci, d’altro canto, esercitava un’attrattiva nei confronti dei giovani: continuava a dare, come durante la Resistenza, prova di serietà, rigore, organizzazione, radicamento sociale; e poi Togliatti aveva un occhio di riguardo per i rampolli di importanti dinastie intellettuali e politiche naufraghe del liberalismo e del fascismo, che cercava di attirare a sé per farne le leve di una nuova classe dirigente.
Dopo la morte di Bruno, Vittorio Foa si dolse di non aver mai chiesto all’amico che cosa volesse dire per lui essere comunista. Un altro compagno di lunga data come Alfredo Reichlin si rammaricò invece che durante i funerali di Trentin la parola “comunista” non fosse mai stata pronunciata. Lo stesso Trentin, molto parco nel parlare di sé in prima persona, non affrontò mai apertamente la questione. In un convegno recente il suo ultimo successore alla guida della Fiom, Gianni Rinaldini, ricordò di averlo sentito a Reggio Emilia durante la polemica del “chi sa parli” – nel 1990, quando Bruno era segretario generale della Cgil, il Pci stava cambiando nome e l’Unione sovietica era sul punto di dissolversi – rispondere che «quando mi sono iscritto al Pci sapevo, e tutti sapevamo, che tutti i membri del Comitato centrale del Pcus erano stati ammazzati [durante le purghe staliniane], ma in quel periodo prevaleva una scelta di schieramento». Ci sarebbe tornato sopra quattro anni più tardi, riferendo di aver scelto a suo tempo di aderire al Pci «perché lo consideravo come una forza decisiva per la trasformazione della società italiana. Ma senza illusioni sui limiti del socialismo reale e sui delitti dello stalinismo; anche se, come tutti, ero lontano dall’immaginarne le atroci dimensioni». Infine, avrebbe riaffrontato per via indiretta il suo rapporto col comunismo in un’intervista del 2002, parlando del padre e ipotizzando che forse, se fosse rimasto in vita, sarebbe anche lui entrato nel Pci, con l’idea di cambiarlo.
Certo che quello che da vent’anni a questa parte sembra una cosa che va spiegata, o che va taciuta, nel 1950 appariva evidentemente meno strana. Un giovane intellettuale di buona famiglia, fresco di guerra partigiana, dalle idee laiche, libertarie e progressiste, ritenne in qualche modo non impossibile, e forse persino naturale, trovar casa nel partito ispirato da Stalin e dall’Unione sovietica, e diretto con pugno di ferro (in guanto di velluto) da Palmiro Togliatti.
In assenza di fonti più ricche, coeve, e più “interne”, non possiamo sovradeterminare le ragioni e persino la consapevolezza politica di quella scelta. Lo stesso Trentin ricordò, in un convegno su Lelio Basso nel 1998, di essere stato fino al 1950 senza partito e «diviso tra molte tentazioni», prima di scegliere l’Ufficio studi della Cgil, su invito di Vittorio Foa. Il lavoro nel sindacato gli consentì un grado maggiore di autonomia rispetto alla vita di partito. La composizione “mista” della Cgil ne era una garanzia; Trentin mantenne infatti rapporti stretti con gli ex azionisti passati nel Psi ed ebbe facoltà di svariare, di esplorare oltre i confini, di tessere relazioni politico-culturali con una certa libertà. I ricordi di chi, come Reichlin, in quegli anni condivise con lui le frequentazioni romane che ruotavano intorno alla casa di Pietro Ingrao, sono di un periodo di grande felicità e di notevole divertimento, anche al di fuori del lavoro. Forse la memoria paga il pegno alla nostalgia per la giovinezza perduta. Ma anche Trentin ricordava il periodo all’Ufficio studi come «una straordinaria esperienza umana, nella quale il lavoro, l’amicizia, le passioni intellettuali comuni, la vita in comune erano inseparabili».
La stessa presenza di Giuseppe Di Vittorio era decisiva nel consentire un clima disteso. La grande “umanità” del bracciante di Cerignola diventato leader del più grande sindacato italiano è ormai quasi proverbiale. Tutto lo separava da Trentin: l’età – 34 anni di differenza: avrebbe potuto essere suo padre –, la provenienza sociale, l’estrazione culturale, la personalità aperta, calda, mediterranea. Tra i due si stabilì un ottimo rapporto, di lavoro e affettivo. Trentin mantenne anche in tarda età una vera e propria devozione per Di Vittorio, e non solo strumentalmente, per legittimare cioè con i riferimenti rituali al vecchio capo glorioso le proprie strategie sindacali, ma anche perché Di Vittorio esercitava su di lui un vero e proprio fascino: rappresentava tutto quello che Bruno non era, né poteva essere, ma che riconosceva come una parte decisiva della propria identità politica. Vi ritrovava il sapore di ciò che aveva sperimentato durante la Resistenza: il segretario della Cgil incarnava «la smentita della teoria leninista del socialismo portato all’esterno della classe operaia e messo nella testa della classe operaia dagli intellettuali d’avanguardia». Di Vittorio era l’uomo che aveva rifiutato, e insegnato ai contadini a rifiutare, di togliersi il cappello e abbassare la testa di fronte ai padroni. Era un analfabeta che si era costruito la sua cultura. Un dirigente terribilmente accentratore nel lavoro quotidiano, ma capace di ascoltare, ed estremamente curioso, duttile. Uno che prendeva le analisi economiche che Bruno gli forniva e le trasformava in un messaggio politico caldo, persuasivo, non dogmatico: in una parola, rivoluzionario. Aveva poi una matrice sindacalista-rivoluzionaria che ogni tanto riemergeva, come quando nel 1953, al congresso della Federazione sindacale mondiale, a Vienna, rivendicò l’autonomia del sindacato dai governi e dai partiti, attirandosi l’ostilità dei sovietici, o come quando, nel 1956, prese posizione a favore degli operai polacchi insorti a Poznam e poi condannò l’invasione sovietica in Ungheria.
Trentin ha molto sottolineato il suo debito culturale nei confronti di Di Vittorio, per aver difeso già negli anni quaranta e cinquanta l’idea di un sindacato non come “cinghia di trasmissione” né come mero strumento di difesa corporativa, ma capace di essere soggetto politico autonomo, di avanzare dei propri programmi, come il Piano del lavoro, e di interloquire con lo stesso governo. L’autonomia, in verità, a quei tempi era piuttosto limitata, ed era possibile solo finché chi la praticava si manteneva fedele alla linea generale che il partito presidiava. La prova del ’56 in questo senso è rivelatrice. Di Vittorio venne subito rimesso in riga da Togliatti. Anche Trentin, che sulla sua scia si era esposto venendo eletto segretario della cellula comunista della Cgil (sede di Corso d’Italia), fu convocato dalla direzione del partito e redarguito pesantemente da Amendola e Pajetta. Disse poi, a distanza di alcuni decenni, di non essere uscito dal Pci per non darla vinta a coloro – e non erano pochi – che vedevano i giovani intellettuali come il nemico interno, o quanto meno come compagni di strada inaffidabili, schizzinosi e senza nerbo, pronti a tagliare la corda al primo mal di pancia. Mantenne fede alla «scelta di schieramento» che aveva fatto sei anni prima, al momento dell’iscrizione al partito, pur senza smettere di essere visto come un comunista anomalo, da tenere d’occhio.
All’ombra dei fatti ungheresi si consumarono alcune vendette tutte interne al mondo sindacale italiano: più di qualcuno approfittò dell’occasione per farla pagare a Di Vittorio e al suo giovane virgulto che stava conquistando troppo spazio. Era cominciato, infatti, dentro la Cgil un processo non indolore di rinnovamento generazionale che stava mettendo ai margini i vecchi dirigenti – come Parodi, Montagnana, Roveda – che si erano formati prima del fascismo. Per certi aspetti assomigliava a quello che stava investendo lo stesso partito comunista, messo in moto da Togliatti dopo l’emarginazione di Secchia. Nel sindacato il punto di svolta era stato il 1955, l’annus horribilis nel quale la Cgil aveva subito una batosta nelle elezioni dei rappresentanti nelle Commissioni interne. Aveva fatto scalpore soprattutto il voto operaio alla Fiat, dove la Fiom era scesa sotto il 40 per cento, quasi dimezzando i suoi consensi rispetto all’anno precedente. Di Vittorio chiese un’autocritica radicale, di fatto esautorando la vecchia guardia sindacale, quella che era stata con Gramsci all’«Ordine nuovo», aveva fondato il partito comunista e aveva dato grandi prove di fedeltà e dedizione in momenti difficili, ma che si era rivelata incapace di comprendere la nuova realtà industriale di un ormai incipiente “miracolo economico”. Il capo mandò subito Trentin a Torino a fare un’indagine sul campo – con Sergio Garavini, Bruno Fernex e qualche altro – per riprendere i contatti con la condizione operaia (ne uscì anche un libro che «fece scandalo», perché smentiva gli stereotipi sull’arretratezza della Fiat), e avviò un profondo ripensamento della propria strategia sindacale, spostando il baricentro dal sud al nord, dalle campagne alle fabbriche, dai braccianti agli operai.
Comincia per Bruno Trentin la stagione delle ricerche sul neocapitalismo. Se nell’ottobre del 1954 si era cimentato ancora intorno ai problemi delle aree arretrate, meno di un anno dopo pubblica un saggio sul Rapporto tra salario e produzione nella odierna grande fabbrica: spiega che è necessario «riportare la soluzione dei problemi della fabbrica e della produzione in primo luogo in seno alla fabbrica e non fuori di essa». Nell’estate del ’56, nella breve stagione di disgelo e di speranze aperta nel campo comunista dalla denuncia dei crimini di Stalin, l’Istituto Gramsci e la sezione per il lavoro di massa del Pci organizzano un convegno su I lavoratori e il progresso tecnico. Trentin vi partecipa con una relazione su Produttività, Human Relations e politica salariale. L’occhio è ormai tutto rivolto alle punte avanzate del capitalismo italiano, all’ingresso nelle fabbriche delle nuove tecnologie, alle moderne forme di organizzazione del lavoro, ai saperi più raffinati messi in campo dalle aziende per controllare, disciplinare, integrare la classe operaia. La gelata dell’autunno complica ma non interrompe il processo di revisione e aggiornamento culturale a sinistra sui temi del lavoro. Dopo la repressione sovietica in Ungheria molti degli intellettuali di punta, quelli più impegnati nella ricerca sul neocapitalismo, escono dal Pci. Ma fuori di esso si aprono altri spazi di confronto, di sperimentazione. Trentin collabora con il Centro di studi e ricerche sulla struttura economica italiana che si è aperto nel ’57 presso la Biblioteca Feltrinelli, insieme a Giolitti, Leonardi, Andreatta, Napoleoni, Momigliano, Lombardini, Sylos Labini. Luigi Longo, il vice di Togliatti, reagisce chiedendo spiegazioni e facendo sentire l’occhio vigile del partito, ma lascia fare.
Lo stesso Ufficio studi della Cgil diventa un luogo di contatto tra culture politiche diverse. Attorno ad esso si riattiva una piccola rete di ex azionisti. E’ significativa soprattutto l’interlocuzione con Franco Momigliano, già autore nel dicembre 1943 di un libretto su Le commissioni di fabbrica e poi a lungo collaboratore di Adriano Olivetti. Foa, Momigliano, Trentin: la nuova cultura sindacale in gestazione ha anche una matrice azionista, attenta a valorizzare nei luoghi di lavoro nuovi organismi di democrazia, di controllo operaio e di potere diffuso. Questa linea emerge in maniera chiara nel 1960. Nei primi giorni di luglio, mentre il paese è infiammato dalle proteste contro il governo Tambroni, Foa e Trentin partecipano al convegno organizzato da Momigliano su Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del processo produttivo con una impegnativa relazione su La Cgil di fronte alle trasformazioni tecnologiche dell’industria italiana. E’, di fatto, il programma con cui tre mesi prima hanno condotto il V Congresso della Cgil: un congresso di svolta, che porta a maturazione il rinnovamento interno avviato nel ’55 e fa emergere un nuovo gruppo dirigente. Così commenterà, in sede di bilancio storico, un’osservatrice attenta e partecipe come Rossana Rossanda:
Fino allora la Cgil di Di Vittorio era stata quella della questione nazionale, dell’arretratezza storica italiana, dei minimi contrattuali da realizzare, del Piano del lavoro. Con il V congresso vince chi dice (sostanzialmente le grandi categorie industriali del Nord, metalmeccanici e tessili, Trentin e Garavini) che la borghesia è mutata, che un progresso tecnologico si è avuto […] e che occorre puntare sulla categorie alte per “tirare” tutta la massa salariale, far saltare la gabbia, ottenere lo statuto dei lavoratori – come infatti avverrà. Da allora inizia quell’egemonia dei metalmeccanici che porterà alla Flm e che occorrerà la rivoluzione tecnologica degli anni ottanta per abbattere.
Nel febbraio del 1962 Trentin viene eletto segretario nazionale della Fiom. Ci va controvoglia – dirà poi – poco convinto di lasciare la sua posizione all’Ufficio studi. Non smetterà mai di essere aggiornato sulla letteratura sociologica internazionale, di studiare e scrivere, di tentare sistematizzazioni teoriche alle proprie strategie sindacali. Ma il gran salto al vertice della federazione dei metalmeccanici segna effettivamente una discontinuità nella sua vita; lo proietta in una dimensione differente, e per molti aspetti esaltante, che aveva in parte sperimentato durante la Resistenza, quando pensiero e azione procedevano insieme e la ricerca era un processo di crescita collettiva che si misurava ogni giorno sul terreno della lotta. Bruno Trentin si congeda dal mondo della ricerca “pura” con una relazione sulle Ideologie del neocapitalismo, pronunciata al convegno dell’Istituto Gramsci sulle Tendenze del capitalismo italiano, nel marzo dello stesso anno. Fa un intervento che stupisce e che divide: stupisce per la vastità della conoscenza del pensiero sociale americano ed europeo più aggiornato, per la capacità di assimilarlo attraverso le categorie gramsciane e poi di applicarlo con scioltezza al contesto italiano; ma anche divide, perché dialoga a distanza con la “nuova sinistra”, con gli operaisti, ed entra in conflitto con la posizione di Amendola di fronte al centro-sinistra. Fa vedere che il neocapitalismo è una forza culturale e ha un progetto di egemonia. Apre una finestra importante sul mondo cattolico, che sa esprimere in quegli anni un pensiero tutt’altro che arretrato e passatista, ma anzi in grado di star ben dentro e persino di orientare le trasformazione in atto nella società. Chiede di stringere alleanze con gli impiegati dell’industria e dei servizi, e soprattutto coi tecnici dell’industria, per non lasciare gli «intellettuali della produzione» preda dell’ideologia neocapitalista.
Tex e gli operai
Il battesimo del fuoco per il nuovo segretario della Fiom è nel luglio del ’62. Era appena andato via da Torino quando esplose, a Piazza Statuto, la rivolta contro i sindacati filoaziendali che avevano firmato un accordo separato con la Fiat. Non erano gli «intellettuali della produzione» a prendersi la piazza, ma i giovani operai dequalificati, arrabbiati, estranei ai linguaggi e alle mediazioni sindacali. Trentin ci vide «una provocazione per far degenerare la protesta dei lavoratori in fatti di ordine pubblico», condotta dai mazzieri del movimento “Pace e libertà” capeggiati da Edgardo Sogno, sostenuti dalla Fiat e tollerati dalle forze dell’ordine. Non riconobbe allora – né lo fece a distanza di anni – la natura tutto sommato spontanea di una protesta giovanile che per certi aspetti annunciava il ’68. Si consumò in quel momento anche il rapporto con gli operaisti riuniti intorno a Raniero Panzieri e ai «Quaderni rossi», con i quali Foa e Trentin avevano fino ad allora dialogato ma che avevano tentato di mettere il cappello sulla rivolta di Torino.
Era comunque il segnale di un clima cambiato, di un’onda che cominciava a crescere. Trentin ebbe la fortuna di starci sopra e di farsi portare in alto, di incrociare la sua biografia di dirigente sindacale con il movimento collettivo più importante che abbia attraversato la società italiana dal dopoguerra. Ma ebbe anche la capacità di mettersi in fase con esso, e contribuì a sostenerlo, orientarlo, farlo durare. La portata di questa svolta – «una specie di catarsi» – che Trentin nei suoi ricordi colloca nell’anno successivo, durante le lotte per il rinnovo del contratto del ’63, traspare dal modo in cui egli ne parlava:
è successo in quel momento lì qualcosa di profondo cioè la ribellione di una generazione di fronte a una fabbrica allora totalmente disumana; ricordo giovani e meno giovani di fronte ad alcune porte della Fiat […] bruciare le tessere del sindacato giallo, che si era appena costituito, e bruciarle piangendo, altri che costringevano i loro compagni che ancora avevano questa tessera a bruciarle e magari baciare la tessera della Fiom che avevano appena acquisito; questi erano, se usiamo il linguaggio del passato, erano i crumiri di qualche settimana prima, quelli che non volevano scioperare, che in poche settimane erano diventati persino, persino dei violenti assertori di un momento di rottura che era vissuto, è stato vissuto allora dalla città, come un momento di liberazione.
E’ un incontro anche fisico con le masse. Un’immersione corporale che mette in gioco sentimenti, emozioni; che fa girare l’Italia e incontrare facce, case, dialetti che altrimenti non si sarebbero mai conosciuti, mai almeno con l’intensità che solo l’esperienza di lottare insieme consente. Trentin nelle sue ricostruzioni metterà sempre in discussione le interpretazioni spontaneistiche dell’“autunno caldo”. Ricorderà che esso fu il frutto di una lunga fase di preparazione sindacale che era cominciata proprio nel ’63: anni di studio, di organizzazione, di lavoro per aprire spazi di rappresentanza nelle fabbriche. In verità la spinta più possente, quella contro l’autoritarismo, per la dignità e l’uguaglianza degli individui, fu un fenomeno così vasto e profondo in quegli anni da terremotare qualsiasi organizzazione, o da mangiarsela. I filmati d’epoca ci consegnano Bruno Trentin nell’autunno del 1969, ai cancelli della Fatme, a Roma, mentre viene inghiottito da una massa di operai che lo portano dentro la fabbrica, per conquistare con questo gesto di illegalità collettiva – era violazione di domicilio – il diritto di assemblea sindacale all’interno dell’azienda. I ricordi ce lo restituiscono durante le trattative con i padroni – alla Fiat, alla Zoppas, alla Zanussi – scandite dalle assemblee dei lavoratori che chiedono di essere informati su tutto e che si fanno sentire, da fuori, «alla cinese», portando suoni, slogan e baccano operaio fin dentro le stanze ovattate del potere aziendale.
E’ l’“operaio-massa” – quel termine che a Trentin non è mai piaciuto – a trainare il movimento. Lui è il capo di una tribù nelle cui vene scorre altro sangue; le tute blu lo riconoscono, lo rispettano, lo ascoltano, lo seguono, ne hanno bisogno, ma sanno che viene da un mondo che non è il loro. Come Tex Willer con i Navajos: anche se sposa la figlia del capo e combatte a fianco degli indiani, rimane sempre un viso pallido. Bruno Trentin era un divoratore dei fumetti di Tex; li leggeva anche di nascosto mentre con un orecchio seguiva le riunioni sindacali. Si portava dietro la passione per i pellerossa sin da quand’era bambino, più ancora che per i moschettieri; la sorella Franca racconta che i primi comizi Bruno li aveva fatti dentro casa, a Tolosa, arringando contro Davy Crockett e Buffalo Bill. Durante il soggiorno ad Harvard, nel dopoguerra, aveva comprato sei incisioni di capi indiani che aveva tenuto sempre con sé, appese in camera, fino alla fine. Si sentiva un mezzo sangue, come Tex: cresciuto tra due nazioni, con una doppia lingua e le radici strappate, attratto dalle terre di confine come luoghi dell’anima fin da trovare il proprio buen ritiro – che gli sarebbe stato fatale – a San Candido, in Alto Adige-Südtirol.
Classico esempio di eroe positivo, senza macchia e senza paura e disposto pur di far trionfare la giustizia anche a violare la legge, Tex ha dalla sua una caratteristica precipua: nervi d'acciaio che gli consentono in ogni circostanza e in ogni pericolo di valutare la situazione e trovare una via di uscita. Questa particolare capacità gli permette in diverse situazioni di mettere in inferiorità psicologica l'avversario di turno tanto da indurlo a sbagliare mira o, a volte, ad abbandonare la partita.
Quanto vale una voce di Wikipedia su un personaggio dei fumetti per delineare l’autopercezione di un dirigente sindacale? A un certo punto, al culmine della rivolta, Trentin si scontra con le tribù ribelli, che rifiutano la sua autorità e scelgono altri capi. C’è un incontro epico, che immortalato in una tavola di Bonelli farebbe la sua giusta figura: quello con Toni Negri, nel 1970, dopo l’estate più calda di Porto Marghera e con l’Italia che sembra sul punto di esplodere. Non erano solo due leader politici che si fronteggiavano, ma due tipi umani, due “razze” differenti che scaturivano dalle stesse terre venete: l’uomo di città e quello di campagna, il nipote di Giorgio Trentin, agrario, e quello di Enea Negri, bracciante, la glacialità distanziante dell’ideologo figlio di un massone e la seduttività erotica del cattivo maestro cresciuto nell’Azione cattolica, gli occhi larghi e chiari di Tex Willer e quelli scuri e sottili del «serpente occhialuto». Negri ricorda che qualcuno chiese a Trentin «se riteneva che il sindacato dei consigli potesse divenire base di un partito operaio nuovo, portatore dell’interesse proletario complessivo», avanzando una profferta rivoluzionaria che era una tentazione; Bruno «tergiversò», mentre «con grugno attento, controllava un futuro che temeva». Poi fu guerra tra i due.
Dal ’68 in avanti Trentin è costretto a combattere sia a destra che a sinistra. Individua una propria strategia sindacale che fa perno sui «consigli di fabbrica», formati dai delegati di linea, di reparto, di fabbrica, emanazione cioè di quei «gruppi omogenei» che sono strumenti di controllo operaio sull’ambiente e sull’organizzazione del lavoro. I Consigli rappresentano il suo contributo teorico e politico più originale, che dà uno sbocco organizzativo alla rivolta, e proprio per questo lo mette in rotta irreversibile con i gruppi di Lotta continua e Potere operaio che ne criticano la natura riformistica, e con la “destra” comunista che intende puntare ancora sulle vecchie, sicure, controllabili Commissioni interne. Ma i Consigli, a ben guardare, sono anche una ripresa del modello di federalismo che era stato di suo padre, poiché esprimono una sovranità politica in senso pieno: l’autonomia della società civile che si affianca allo Stato, ai partiti e allo stesso sindacato confederale. E sono, infine, qualcosa che non è tutto nelle mani e nella testa di Bruno Trentin, ma che egli vede agire, correre, moltiplicarsi nella società, e a cui cerca di dare parole. E’ già questa la rivoluzione, può rispondere a chi gli propone di farla.
Nel breve saggio che scrive su Sindacato, organizzazione e coscienza di classe fa un bilancio degli ultimi dieci anni: parla di «una svolta di carattere storico nei contenuti della coscienza di classe in Italia». Ma sembra aver avuto lui per primo una svolta epistemologica; persino la prosa è cambiata: meno tormentata, più diretta. Parla di cose che ha visto e toccato, non solo studiato. Racconta dello sviluppo di una conoscenza collettiva che si svolge a partire dalle fabbriche e che è in sé una conquista di potere. Sente il bisogno di avviare – mentre il movimento ancora non si è assestato – un «processo di auto-coscienza», non per vivisezionare quella esperienza come se fosse cosa morta, non per delegarne l’interpretazione agli «specialisti della ricerca», ma per «suscitare tutto quello che di vivo e di fecondo c’è tuttora in essa, per farlo crescere e per farlo giungere fino ai suoi necessari approdi: approdi non solo politici ma anche teorici che un’esperienza di massa di questa qualità contiene sempre».
Pio Galli, che fu suo vice in Fiom, ha raccontato la frenesia di allora, simile a quella che Bruno aveva vissuto nei mesi che erano seguiti alla Resistenza: i viaggi continui in tutta Italia per riunioni e assemblee, il bisogno di ascoltare e vedere, di prendere appunti per non perdere nulla, di leggere tanto, di divorare esperienza e costruire conoscenza. C’erano fili di memorie interrotte da riannodare e pagine del passato da rileggere con occhi nuovi. Una rivoluzione culturale di questo tipo assomiglia a un riadattamento gestaltico: si vedono cose che erano sempre state lì senza che si riuscisse a metterle a fuoco, si riconoscono come parte di un tutto tanti particolari che fino ad allora erano percepiti come separati. Trentin collega certo marxismo (non tutto) a certo umanesimo cristiano (non tutto); intreccia e confronta il pensiero di Gramsci, Rosa Luxemburg, Simone Weil e di suo padre Silvio. Qualcosa di simile stanno vivendo, a modo loro, gli operai nelle fabbriche del lavoro meccanizzato e parcellizzato, nel momento in cui elaborano collettivamente una coscienza non frantumata di sé e del proprio lavoro. Il movimento di base che dà vita alla federazione unitaria dei metalmeccanici (Flm) si alimenta di questo senso di scoperta e di apertura che abbatte i confini del sindacato e della politica, che riempie il tema “lavoro” di un contenuto universale: pone, a partire dalla condizione operaia, il problema dell’uomo frustrato e oppresso (non solo sfruttato); riscopre il nesso inscindibile che vi è «tra la contestazione di una organizzazione del lavoro nella fabbrica e la contestazione della struttura economica della società e dell’organizzazione della società civile».
A questo punto Trentin ha in mano un filo che cercherà in tutti i modi di non lasciar cadere. Ma mentre gioisce per averlo trovato, si accorge che già lo scenario sta cambiando: il labirinto si ricrea, le conquiste di un momento sono pronte a sfuggire. Insegue il lavoro e il potere che scappano via dalla fabbrica proprio mentre, dentro la fabbrica, i Consigli si burocratizzano, diventano sempre più sterili, mere strutture difensive che si fossilizzano attorno a élites ristrette e capi carismatici. Alle rigidità introdotte nel controllo della forza lavoro le grandi imprese già nei primi anni settanta rispondono esportando il loro modello tecnologico e organizzativo in zone più sicure, come Spagna, America Latina, Terzo mondo. E poi esternalizzando pezzi di produzione, trasformando gli operai in artigiani, allargando la sacca dei lavoratori a domicilio, in nero e disoccupati: disarticolando una coscienza collettiva appena conquistata. Ora Trentin rivendica per il sindacato un ruolo a tutti gli effetti – e più tradizionalmente – “politico”, da giocare cioè anche fuori dei luoghi di lavoro. C’è uno Stato da riformare, dopo il fallimento del centro-sinistra. C’è da contrastare la strategia della tensione, che ha cominciato a colpire, a Milano, proprio durante l’“autunno caldo”. E ci sono spinte ribellistiche e populiste che rischiano di essere cavalcate dalla destra: è la Fiom a premere, nel 1972, affinché tutto il sindacato scenda in forze a Reggio Calabria per fronteggiare la rivolta dei “boia chi molla”. Di fronte alla crisi economica che si apre nel 1973, Trentin interloquisce col governo per orientare le politiche pubbliche a sostegno dell’occupazione; chiede al sindacato e agli stessi operai di farsi carico degli squilibri territoriali tra Nord e Sud; apre una vertenza contrattuale con le imprese ottenendo che i Consigli siano informati sulle strategie delle aziende e possano controllarne gli investimenti; ipotizza la nascita di Consigli di zona, cioè «nuove forme di partecipazione e di direzione unitaria sul piano territoriale e nazionale […] alla misura dei nuovi e complessi temi da affrontare e capaci di suscitare e di interpretare la partecipazione diretta, il protagonismo, libero da steccati precostituiti, di tutti i lavoratori interessati». Al Congresso del Pci del 1975 dà la sua adesione alla linea del “compromesso storico” con queste parole:
Noi non chiediamo di entrare nella stanza dei bottoni, perché non crediamo alla stanza dei bottoni, chiediamo di partecipare al governo della società, di promuovere attraverso una più ricca partecipazione democratica delle masse, anche attraverso le loro lotte sindacali, alla costruzione di uno Stato rinnovato, fondato sulla dialettica reale delle forze reali e politiche e sulla ricerca del consenso.
Il ’77 è un altro anno di svolta, che scandisce la biografia individuale di Trentin non meno di quella collettiva del suo sindacato. Il 17 febbraio il segretario generale della Cgil Luciano Lama è cacciato dalla Sapienza, a Roma, da un nuovo proletariato giovanile che rifiuta la cultura del lavoro e contesta l’autorità del Pci e del sindacato. Meno di un mese più tardi, nella rossa Bologna la frattura tra “nuova” e “vecchia” sinistra si approfondisce. Dopo l’uccisione di Francesco Lorusso nel corso di una manifestazione, i Consigli di fabbrica e la Camera del lavoro rifiutano di appoggiare la protesta indetta dalla sinistra extraparlamentare che accusa i carabinieri per l’omicidio, e anzi criticano apertamente il ricorso alla violenza da parte del movimento studentesco.
Due mesi dopo, il 15 maggio, sempre a Bologna, al congresso nazionale della Fiom Trentin passa la mano e non ripresenta la sua candidatura al vertice. Vittorio Foa ha ricordato la motivazione che Giorgio Amendola gli avrebbe riferito, in separata sede, per spiegare l’allontanamento di Bruno dalla Fiom: «il mio partito non può più dire ad uno quello che vuole che lui faccia, però può impedire ad uno di fare quello che vuole». Trentin sarà poi eletto segretario confederale della Cgil: una “promozione”, anche questa volta subita più che cercata, che sancisce la fine di un ciclo. Si congeda dai metalmeccanici con una relazione a tutto tondo, che analizza le ragioni della crisi – economica, politica, sociale – che il paese sta attraversando. Tex Willer offre solo uno sguardo severo e corrucciato ai nuovi “indiani metropolitani” che assediano la città, i quali di rimando lo vedono ormai come un ranger alla pari di tutti gli altri, venuto a mettere ordine.
Autunno sindacale
Ancora una volta, però, sarà un contributo teorico ben più ponderato a segnare il passaggio di fase. Una lunga introduzione, di più di 130 pagine, alla raccolta di suoi saggi Da sfruttati a produttori. Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal miracolo economico alla crisi segue il filo di una riflessione sulle trasformazioni del lavoro che parte dagli anni ’50 e si affaccia sul presente. C’è, ad esempio, un excursus lucidissimo – e “profetico” – sull’importanza che ha avuto «l’assenza sul mercato del lavoro, in Italia, negli anni decisivi del decollo industriale, di una massa fluttuante di manodopera immigrata» per rendere possibile l’“autunno caldo”, a confronto con gli altri paesi europei dove proprio l’immigrazione straniera è stata utilizzata negli stessi anni come strumento per calmierare il mercato del lavoro e indebolire il sindacato. Ma la comparazione col passato e l’altrove serve in primo luogo a cercare una chiave per comprendere il qui e ora, i nodi della ristrutturazione del sistema produttivo e della mobilità della forza lavoro, la difficoltà di adeguare il sindacato alle nuove forme di occupazione. Sarà questo il suo rovello teorico, che lo accompagnerà lungo tutti gli anni ottanta e novanta.
Nel febbraio del 1978, all’assemblea dei delegati e dei consigli di fabbrica al Palazzo dei congressi dell’Eur il sindacato intraprende la strada dei “sacrifici” in cambio di riforme e nuova occupazione. Sono i mesi del “compromesso storico” che precedono il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Trentin, in una relazione interna al Direttivo della Cgil, parla di un «oscuramento del ruolo politico della grande fabbrica negli orientamenti generali del movimento sindacale operaio italiano».
Un anno dopo, proprio dentro le grandi fabbriche del nord lo stesso sindacato è nel mirino delle Brigate rosse. Il 24 gennaio 1979 a Genova viene ucciso Guido Rossa, operaio all’Italsider, emigrato dal Veneto, iscritto al Pci, delegato della Fiom. Trentin ne rimane particolarmente scosso: Rossa è la proiezione del suo modello di operaio: colto, creativo, identificato col suo lavoro, simile a quello che Primo Levi aveva appena raccontato ne La chiave a stella. Vent’anni più tardi lo avrebbe ricordato con queste parole:
Lui era allora, anche se pochi lo sanno, uno dei più grandi arrampicatori italiani, un accademico del Club alpino, aveva fatto molte vie nuove ed era uno degli aspetti della sua personalità estremamente poliedrica, era riconosciuto da tutti, io ho parlato a lungo con i dirigenti della sua fabbrica, come qualcosa di più di un operaio altamente specializzato, era un tecnico pieno di capacità inventiva, era uno scultore, era un pittore e ha fatto dei quadri interessanti davvero, ho visto anche in casa sua, ed era anche un grande alpinista; questo non gli ha impedito non soltanto di esprimere io credo un po’ tutte le sue qualità in questo lavoro che amava e che reinventava ogni giorno, ma anche di impegnarsi a fondo in una battaglia di cui avvertiva tutta la portata, la responsabilità; e me ne parlava proprio quando ci trovavamo magari in una festa dell’Unità a Genova dove lui faceva il cuoco e serviva un piatto di pasta col pesto che era la sua specialità.
Trentin si affaccia sugli anni ottanta scorgendo i prodromi di un’altra «rivoluzione passiva» che sta mettendo in crisi l’egemonia della classe operaia e delle sue organizzazioni. Si scontra ancora una volta con Amendola nell’immaginare la via d’uscita. Il vecchio leader dell’ala riformista del Pci propone una soluzione politica che ancori il partito ad una scelta di governo. Trentin invece, ormai uscito dall’orbita della “sinistra comunista” scoppiata dopo il ’68, cerca ancora nel sociale – nel lavoro, anche se non più esclusivamente nella grande fabbrica – il bandolo della matassa da cui ripartire. In una lunga intervista resa all’amico Bruno Ugolini nel 1980, egli dice che «le nuove forme di lavoro artigianale che risorgono nelle città del capitalismo, la vitalità che dimostrano certe attività cooperative e autogestite, la moltiplicazione, sia pure in forma “selvaggia”, delle forme di alternanza fra scuola (lavoro) e lavoro, le stesse forme di doppio lavoro, che hanno spesso una motivazione complessa e non solo massimizzazione del reddito, sono altrettante testimonianze del fatto che una nuova concezione del lavoro, antagonista con le strutture dominanti, può essere anche la fucina di una nuova concezione della politica». Sostiene, insomma, che il tramonto della grande fabbrica taylorista sta aprendo agli individui delle opportunità di liberazione e autorealizzazione nel lavoro, e che la trasformazione in corso può essere cavalcata da sinistra, se adeguatamente compresa e non solo demonizzata.
Non sarà così. L’analisi non basterà a surrogare un soggetto sociale magmatico e disperso. E il sindacato si troverà da allora a combattere quasi solo battaglie difensive, a gestire una ritirata strategica di dimensioni epocali.
Fortunato in tante occasioni, al suo ultimo appuntamento con la grande storia Bruno Trentin arriva in una posizione molto difficile. È eletto segretario generale della Cgil nell’ottobre del 1988, con il Pci in piena crisi e a pochi mesi dal grande cataclisma dell’89. La sinistra italiana che viene dal movimento operaio si aggrappa al leader della sua ultima stagione vincente, quella dell’“autunno caldo”. Per la sua biografia oltre che per il percorso culturale Trentin sembra incarnare un’altra tradizione possibile, che si riallaccia ai principi della rivoluzione francese, aggirando l’ostacolo ormai impronunciabile di Lenin e del ’17, ma anche evitando di riconfluire a capo chino nell’alveo del socialismo riformista che ha ora il volto arrogante di Bettino Craxi. Trentin si gioca la sfida senza infingimenti. Propone alla sua organizzazione di «cambiare pelle»: parla di «sindacato dei diritti», dice che il modello dell’occupazione a tempo pieno per tutta la vita è tramontato e che bisogna governare la flessibilità e garantire ai lavoratori il diritto all’informazione e alla formazione permanente, inscrive nel codice genetico della nuova Cgil la «rivoluzione femminile», la sostenibilità ambientale, il diritto di ciascuno «all’autorealizzazione di sé, come persona inconfondibile con una massa indistinta di individui». Come negli anni cinquanta aveva contribuito a spostare il baricentro della Cgil dai braccianti agli operai, ora Trentin sembra puntare sul settore dei servizi e delle nuove professioni, più che su quello dell’industria tradizionale. Ma la critica del capitalismo non è più all’ordine del giorno. Anzi, la parola capitalismo non compare in tutto il discorso. Il “sol dell’avvenire” che bruciava nelle pagine adolescenziali del Diario di guerra è stato sostituito da tanti piccoli “soli”: astri individuali, più a portata di mano, ma che scaldano meno.
La crisi politica e finanziaria che si apre in Italia nei primi anni novanta scaraventa il sindacato in prima linea, quale unica istituzione nazionale immune dalle inchieste giudiziarie e in grado di reggere l’urto delle spinte antisistema che la Lega e la mafia producono al nord e al sud del paese. Schierarsi a difesa dello Stato esistente sarà, per il federalista, rivoluzionario e autonomista Bruno Trentin, una sorta di nemesi storica. In questa supplenza istituzionale il sindacato brucia i residui di popolarità accumulata e faticosamente difesa nei due decenni precedenti. L’assunzione di una responsabilità politica tanto impegnativa – non più sostenuta, come negli anni settanta, da un radicamento sociale adeguato – accentua la sensazione di chiusura aristocratica che a Trentin viene già imputata come dato caratteriale. All’interno della Cgil aumentano le voci critiche: alla rivista «Rassegna sindacale» viene spedita una lettera che chiede di cambiare «un ceto politico-sindacale oligarchico composto da troppi intellettuali illuminati». Il segretario generale in persona risponde, con un riflesso elitario che dava ragione a chi glielo rimproverava, che «leggere qualche libro fa bene; a cominciare magari da una enciclopedia tascabile, per comprendere il significato delle parole (è una scoperta appassionante) e per trovare, se proprio uno ci tiene, gli insulti più appropriati».
Il momento peggiore Trentin lo vive nell’estate del 1992, una delle più tragiche della recente storia italiana. Il 27 giugno, dopo l’omicidio di Giovanni Falcone, scende a Palermo per parlare in piazza Politeama alla grande manifestazione contro la mafia promossa dalle tre confederazioni sindacali. Un mese più tardi è chiamato a palazzo: il presidente del consiglio Amato chiede ai sindacati un’altra “assunzione di responsabilità”, minacciando altrimenti di dichiarare la bancarotta dello Stato. E’ l’ennesimo socialista negativo che Bruno incontra sulla sua strada (spalleggiato da un altro all’interno della Cgil, Ottaviano Del Turco): lo mette davanti – il 31 luglio 1992, a fabbriche chiuse – a un accordo che cancella la “scala mobile” e impone un blocco alle contrattazioni aziendali. E’ un testo che penalizza i lavoratori dipendenti e viola il mandato che il segretario aveva ricevuto dalla sua organizzazione. E contraddice il tema che gli era sempre stato caro dell’“autonomia” del sindacato, inteso come forza che ha le proprie radici nella rappresentanza sociale. Trentin si piega e firma. Subito dopo dà le dimissioni, la Cgil le respinge, ma comincia per lui quello che sente come un «piccolo calvario»: in autunno il governo procede a una politica di svalutazione competitiva, che genera inflazione e scarica così la necessità di far quadrare il bilancio dello Stato su salari e stipendi. Sarà un altro “autunno caldo” nelle piazze, ma questa volta a Trentin toccano gli insulti e i bulloni dei lavoratori. Gianni Rinaldini, che lo accompagnò durante la sua prima uscita pubblica dopo il 31 luglio, ricorda le aggressioni che il segretario generale della Cgil subì dal “popolo di sinistra”, a Reggio Emilia, lungo le stradine della Festa nazionale dell’Unità.
Trentin recupererà qualcosa l’anno seguente, quando il governo Ciampi promuove un nuovo accordo meno vessatorio. Poi abbandona definitivamente la segreteria della Cgil per collocarsi all’Ufficio programma. Si apre così l’ultima fase della sua vita, la stagione delle testimonianze e dei ripensamenti. E’ convinto che il mondo del lavoro come è stato conosciuto nel Novecento sia esploso, che le grandi concentrazioni di uomini impegnati in attività ripetitive stiano scomparendo, che il futuro sia altrove. Cerca una nuova immersione nella società che lo metta a contatto con i lavoratori precari, flessibili, non tutelati ma orgogliosi della propria autonomia. Così racconta questa sua esperienza in un’intervista resa a Pino Ferraris, nel 1997:
Io ho lavorato molto in questi settori, ho fatto molte assemblee e riunioni con questi ragazzi che lavorano nell’editoria, nell’informatica, persino nelle sale corse o nelle discoteche. Se noi gli diciamo, come spesso ripetiamo loro con pigrizia e dogmatismo, in realtà voi siete dei subordinati, vi hanno truffato, vi hanno chiamato lavoratori autonomi ma non lo siete, voi dovete fare la battaglia per ridiventare salariati, la risposta che riceviamo è radicalmente negativa. Ciò che ti impressiona è quando senti dire da ragazzi, che hanno mansioni poco qualificate, che fanno lavori poveri: «non ci stiamo più a ritornare al lavoro salariato». Essi attribuiscono a questa autonomia di decisione, anche se così segnata da ingiustizie profonde, un’importanza enorme.
Scrive molti libri, da solo o in dialogo, dedicati a indagare il presente e il passato. Il più significativo tra questi è La città del lavoro: una “summa” del suo pensiero volta a contrastare sia gli apologeti della fine del lavoro che i nostalgici del fordismo, alla ricerca di un’«altra sinistra» e delle sue radici.
Nel 1999 Bruno Trentin è eletto parlamentare europeo nei Ds. Riceve riconoscimenti internazionali per il suo glorioso passato, ma si sente isolato e messo da parte. La conoscenza che produce non si incontra più con le correnti calde della storia. Nell’agosto del 2006, a ottant’anni, mentre è in vacanza a San Candido subisce un banale incidente in bicicletta che lo lascia gravemente invalido. Muore dopo un anno. Ai funerali, davanti alla sede della Cgil, per un suo desiderio Giovanna Marini lo saluta cantando Les temps des cerises, l’inno dei comunardi di Parigi del 1871, We shall overcome di Joan Baez e il canto della Resistenza italiana Bella Ciao.
Nota bibliografica
Molte delle informazioni utilizzate per questo profilo sono tratte dalle testimonianze autobiografiche di Bruno Trentin, come l’intervista resa nel 1986 a Cesco Chinello (conservata ora presso l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e ampiamente citata nel libro di Chinello, Sindacato, Pci, movimenti negli anni sessanta. Porto Marghera-Venezia, 2 voll., Franco Angeli-Insmli, Milano 1996), le tre interviste filmate nel 1998 da Franco Giraldi (conservate in video e in trascrizione presso l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico e utilizzate per il film su Trentin Con la furia di un ragazzo, realizzato da Giraldi nel 2008) e quelle – di Bruno e di altri – pubblicate nel libro Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil, a cura di Iginio Ariemma e Luisa Bellina, Ediesse, Roma 2008. Utili documenti e testimonianze di e su Trentin si possono trovare nel sito internet a lui dedicato: http://www.brunotrentin.it. Qui è contenuta anche la lectio doctoralis del 2002, con cui questo saggio si apre, oltre al testo della laudatio – un profilo biografico – pronunciata nell’occasione dal prof. Piero Bolchini.
Sulla giovinezza di Bruno e il rapporto col padre, vedi in primo luogo il saggio di Luisa Bellina, Dalla Resistenza alla Treviso del dopoguerra, in Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil, cit., pp. 111-146, le interviste ai fratelli Bruno, Franca e Giorgio Trentin pubblicate originariamente nel libro Nella Resistenza. Vecchi e giovani a Venezia sessant’anni dopo, a cura di Giulia Albanese e Marco Borghi, Iveser-Nuova Dimensione, Venezia-Portogruaro 2004, pp. 137-204, la biografia di Frank Rosengarten, Silvio Trentin dall’interventismo alla Resistenza, Feltrinelli, Milano 1980, e gli scritti di Silvio Trentin (la lettera del 23 ottobre 1943 in cui questi esprime a Emilio Lussu la sua posizione sul Partito d’azione è tra gli Scritti inediti. Testimonianze e studi, a cura di Paolo Gobetti, Guanda, Parma 1972, pp. 25-28; alle pp. 295-318 è riportato l’Abbozzo di un piano tendente a delineare la figura costituzionale dell’Italia al termine della rivoluzione federalista in corso di sviluppo, poi pubblicato nel IV volume delle “Opere scelte di Silvio Trentin”: Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943, a cura di Norberto Bobbio, Marsilio, Venezia 1987, pp. 341-360). Prezioso il Diario di guerra (settembre-novembre 1943) di Bruno, con introduzione di Iginio Ariemma e postfazione di Claudio Pavone (Donzelli, Roma 2008).
Una ricostruzione del percorso universitario di Bruno a Padova e della tesi di laurea è stata fatta da Giuseppe Zaccaria al convegno Bruno Trentin. La cultura del lavoro e della libertà, Padova, 16 ottobre 2008. Sulla “profezia” di Leo Valiani vedi Vittorio Foa, Il cavallo e la torre. Riflessioni su una vita, Einaudi, Torino 1991, p. 225; ivi, a p. 148 Foa attribuisce a Valiani, e non a Trentin, la primogenitura della frase «La bandiera rossa sventola su Berlino».
Il rimpianto per non aver chiesto a Bruno le motivazioni del suo essere comunista è espresso da Foa in un’intervista del 2007 pubblicata in Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil, cit., p. 196. La testimonianza di Alfredo Reichlin sull’amico si trova nell’articolo Trentin e la storia italiana/1. Il debito della sinistra, in «Argomenti umani», n. 9, 2008, pp. 31-36 (vedi anche Riccardo Terzi, Trentin e la storia italiana/2. Una cultura controcorrente, ivi, pp. 37-43). Il ricordo di Gianni Rinaldini è stato riferito al convegno Il futuro del sindacato dei diritti, Roma, 24 ottobre 2008. La motivazione dell’adesione al Pci è in Bruno Trentin, Il coraggio dell’utopia. La sinistra e il sindacato dopo il taylorismo, intervista di Bruno Ugolini, Rizzoli, Milano 1994, p. 186. L’ipotesi di Trentin sul futuro politico del padre è in un’intervista del 2002, ora in Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil, cit., p. 99.
Le testimonianze di Trentin sul suo primo periodo romano sono citate in Luisa Bellina, Dalla Resistenza alla Treviso del dopoguerra, cit., p. 145-146. Su Di Vittorio e il 1956, vedi Bruno Trentin, Il coraggio dell’utopia, cit., pp. 182-189 e Adriano Guerra, Bruno Trentin, Di Vittorio e l’ombra di Stalin. L’Ungheria, il Pci e l’autonomia del sindacato, Ediesse, Roma 1997. L’inchiesta alla Fiat del 1955 fu pubblicata col titolo Nella più grande fabbrica d'Italia. Il monopolio FIAT e l'economia italiana, le nuove forme di organizzazione aziendale, le condizioni di vita e di lavoro delle maestranze occupate alla FIAT-Mirafiori in una inchiesta della Cgil, prefazione di Secondo Pessi, Edizioni Lavoro, Roma 1956. Un’ampia disamina dei risultati dell’inchiesta in Giuseppe Bonazzi, Sociologia alla Fiat. Ricerche e discorsi 1950-2000, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 17-22. Un cenno sulle reazioni all’uscita del libro nell’intervista di Trentin a Giovanni Rispoli, Quegli anni in Corso d’Italia. Ricordo di Tonino Tatò, in «Rassegna sindacale», n. 1, 18 gennaio 1993, pp. 32-34. Della partecipazione di Trentin al Congresso internazionale sul problema delle aree arretrate (i cui atti furono pubblicati dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, presso Giuffrè, Milano, 1954) dà notizia il saggio di Salvatore Misiani, La cultura, in Adolfo Pepe, Pasquale Iuso, Simone Misiani, La Cgil e la costruzione della democrazia, III volume della “Storia del sindacato in Italia nel ‘900”, Ediesse, Roma 2001, p. 343. L’articolo Rapporto tra salario e produzione nella odierna grande fabbrica, venne pubblicato nel numero di settembre 1955 di “Rinascita”. La relazione su Produttività, Human Relations e politica salariale al convegno su I lavoratori e il progresso tecnico uscì nel fasc. n. 4, agosto 1956, di «Critica economica», pp. 54-68 e ora è ripubblicata in appendice al volume di Adolfo Pepe, Pasquale Iuso, Simone Misiani, La Cgil e la costruzione della democrazia, cit., pp. 447-457. Sulla partecipazione di Trentin al Centro di studi messo in piedi da Giangiacomo Feltrinelli, vedi Carlo Feltrinelli, Senior Service, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 109-110. Per un profilo di Franco Momigliano, vedi Salvatore Misiani, La cultura, cit., pp. 260-264 e 323-325; la relazione di Foa e Trentin (La Cgil di fronte alle trasformazioni tecnologiche dell’industria italiana) al convegno da lui organizzato nel 1960 è in Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del processo produttivo, a cura di Franco Momigliano, Milano, Feltrinelli, 1962, vol. I, pp. 161-212. Il commento di Rossana Rossanda è tratto dal libro di Cesco Chinello, Sindacato, Pci, movimenti, cit., tomo I, p. 156. Il saggio di Bruno Trentin, Ideologie del neocapitalismo (relazione al convegno Tendenze del capitalismo italiano, Roma, Istituto Gramsci 23-25 marzo 1962) è stato pubblicato come estratto a sé dagli Editori Riuniti nel 1962 e, recentemente, nel libro Bruno Trentin, Lavoro e libertà. Scritti scelti e un dialogo inedito con Vittorio Foa e Andrea Ranieri, a cura di Michele Magno, Ediesse, Roma 2008, pp. 39-87, sotto il titolo originario di Le dottrine neocapitalistiche e l’ideologia delle forze dominanti nella politica economica italiana. Sul conflitto tra le tesi espresse al convegno da Trentin e da Amendola, vedi Franco De Felice, Nazione e sviluppo: un nodo non sciolto, in Storia dell’Italia repubblicana. Volume quarto. La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri. I. Politica, economia, società, Einaudi, Torino 1995, pp. 807-810.
Su “piazza Statuto”, oltre ai ricordi di Foa ne Il cavallo e la torre, cit., p. 260 e a quelli di Romolo Gobbi in Com’eri bella, classe operaia, Longanesi, Milano 1989, pp. 69-71 e nella sua intervista contenuta nel cd rom allegato al libro di Guido Borio et al., Futuro anteriore. Dai «Quaderni rossi» ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano, DeriveApprodi, Roma 2002, vedi quelli di Trentin nelle interviste citate all’inizio di questa nota e nel suo libro Autunno caldo. Il secondo biennio rosso 1968-1969, intervista di Guido Liguori, Editori Riuniti, Roma 1999, pp. 28-29. I filmati a cui si fa riferimento sono quelli girati da Silvano Agosti e da lui proposti in un ritratto di Bruno Trentin incentrato sull’“autunno caldo” dal titolo Il senso della lotta (2008). Sulla lettura di Tex e il mito dei pellerossa, vedi la testimonianza di Andrea Dapporto in Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil, cit., p. 269 e quelle citate da Luisa Bellina, ivi, pp. 114-115. Sull’incontro Trentin-Negri, vedi Toni Negri, Pipe-line. Lettere da Rebibbia, Einaudi, Torino 1983, p. 125. Il punto di vista di Trentin in Aldo Grandi, La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, Einaudi, Torino 2003, pp. 102-104. Sui rapporti di Trentin con la “sinistra comunista” negli anni sessanta, vedi le memorie di Pietro Ingrao, Volevo la luna, Einaudi, Torino 2006, pp. 314 e 334, di Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino 2005, p. 313, di Cesco Chinello, Un barbaro veneziano. Mezzo secolo da comunista, Il Poligrafo, Padova 2008, oltre al saggio di Fabrizio Loreto, L’«anima bella» del sindacato. Storia della sinistra sindacale, Ediesse, Roma 2005.
Tra gli scritti di Trentin sulla stagione dei Consigli di fabbrica: La tematica consiliare all’interno delle organizzazioni nazionali dei metalmeccanici, in Guido De Masi et al., Consigli operai e consigli di fabbrica, Savelli, Roma 1978, pp. 90-112 (trascrizione dell’intervento pronunciato nel 1971 e pubblicato in prima edizione nel volume I consigli operai, a cura del Circolo G. Leopardi di Bologna, La nuova sinistra, Roma 1972); Sindacato, organizzazione e coscienza di classe, in Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-1973, a cura di Aris Accornero, «Annali» della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a. XVI, 1974-1975, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 931-947; Da sfruttati a produttori. Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal miracolo economico alla crisi, De Donato, Bari 1977; Il sindacato dei consigli, intervista di Bruno Ugolini, Editori Riuniti, Roma 1980.
La testimonianza di Pio Galli è nel suo Da una parte sola. Autobiografia di un metalmeccanico, Manifestolibri, Roma 1997, p. 160. L’intervento di Trentin al XVI Congresso del Pci è negli Atti e risoluzioni (Editori Riuniti, Roma 1975), come citato da Romolo Gobbi nel suo Com’eri bella, classe operaia, cit., p. 166. Il ricordo di Foa sulla confidenza ricevuta da Amendola nel 1977 è nella raccolta di scritti di Bruno Trentin, Lavoro e libertà, cit., p. 342. Per una sintesi della relazione di Trentin al congresso della Fiom vedi la cronaca di Bruno Ugolini, Trentin: una battaglia complessiva capace di investire le articolazioni dello Stato, «l’Unità», 16 maggio 1977, p. 2.
Ampi stralci della relazione di Trentin al Comitato direttivo della Cgil (24 febbraio 1978) sono pubblicati da Lorenzo Bertucelli, La gestione della crisi e la grande trasformazione (1973-1985), in Lorenzo Bertucelli, Adolfo Pepe, Maria Luisa Righi, Il sindacato nella società industriale, IV volume della “Storia del sindacato in Italia nel ‘900”, Ediesse, Roma 2008, pp. 282-283. La citazione dal libro Il sindacato dei consigli, cit., è a p. 223. Un bilancio sintetico della segreteria Trentin è tracciato da Adolfo Pepe nel saggio I lunghi anni ottanta (1980-1993), in Lorenzo Bertucelli, Adolfo Pepe, Maria Luisa Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 349-356. Le proposte di Trentin per il rinnovamento del sindacato sono nella relazione pubblicata in Il sindacato dei diritti. Atti della Convenzione programmatica della Cgil. Chianciano 12-14 aprile 1989, Ediesse, Roma 1989, pp. 11-35. Il botta e risposta su «Rassegna sindacale» è stato richiamato da Renato D’Agostini nell’editoriale che apre lo speciale su Bruno Trentin nel sito web della stessa rivista, dove sono reperibili anche numerosi documenti scritti e audiovisivi (http://archivio.rassegna.it/2007/speciali/articoli/trentin/prima.htm). I ricordi di Trentin sull’accordo del 31 luglio 1992 sono tratti dalle interviste a Franco Giraldi citate all’inizio di questa nota, dal dialogo con Vittorio Foa e Andrea Ranieri pubblicato in appendice al libro Lavoro e libertà, cit., e dalla testimonianza resa da Gianni Rinaldini al Convegno Il futuro del sindacato dei diritti, già richiamato. L’intervista a Pino Ferraris è nel n. 14/15 di «Parolechiave», dedicato al tema Lavoro, dicembre 1997, pp. 21-33.
Gli ultimi libri di Trentin sono: Il coraggio dell’utopia, cit.; Lavoro e libertà nell'Italia che cambia, Donzelli, Roma 1994; Nord sud. Lavoro, diritti e sindacato nel mondo, (coautore Luis Anderson), a cura di Massimo Mascini, Ediesse, Roma 1996; La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Feltrinelli, Milano 1997; Il lavoro possibile. Prospettive di inizio millennio, dialogo con Angelo Varni, (coautore Carlo Callieri), Rosenberg & Sellier, Torino, 1997; Di Vittorio e l'ombra di Stalin, cit.; Autunno caldo, cit.; Processo alla crescita. Ambiente, occupazione, giustizia nel mondo neoliberista, (coautrice Carla Ravaioli), Editori Riuniti, Roma 2000; La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale, Editori Riuniti, Roma 2004.
Un ringraziamento ad Alfiero Boschiero e Gilda Zazzara per l’aiuto e gli scambi di idee.