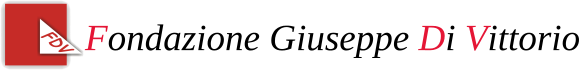Di lui avremmo oggi gran bisogno, Alfredo Reichlin
Ascoltando in questi giorni tante voci e partecipando al travaglio di una sinistra che vuole uscire dai vecchi confini per costruire una forza nuova capace di ridare al paese un futuro ho molto pensato a Bruno Trentin. Bruno protagonista della storia profonda dell’Italia repubblicana.
Parlo di quel fattore essenziale che spiega lo strano “miracolo” per cui un paese che ancora sessanta anni fa era popolato da contadini analfabeti e da una piccola borghesia povera, con una classe dirigente prostituita al fascismo, si è trasformata in pochi anni in una delle maggiori potenze industriali del mondo. Sono gli uomini come Trentin che hanno fatto quel miracolo. Ma perché l’hanno potuto fare? E’ su questo che bisognerebbe dire qualcosa riandando con la memoria a quel mondo reale e a quelle vite. Certo, l’hanno fatto per le loro virtù. Ma io penso anche a qualcosa di cui non è facile oggi parlare senza finire nella spazzatura dove giacciono i “vecchi arnesi” del comunismo. Mi ha colpito che, durante il funerale di Bruno, la parola PCI non è stato nemmeno nominata.
Io sono tra quei vecchi arnesi. Ma mi chiedo come si può parlare di Bruno e della sua singolare figura così “atipica” (è vero) rispetto a una idea deforme e astratta del comunismo italiano e come si può parlare di tante altre figure anch’esse tutte “atipiche” come Napolitano o come Di Vittorio o Ingrao o Amendola, o Macaluso o Giolitti senza porsi una domanda che ci riporta al cuore della vicenda italiana. La domanda è questa: essi furono comunisti per caso oppure perché quello fu allora il riformismo italiano, o perlomeno una delle sue matrice essenziali? La verità è che “atipico” era il PCI. Questa strana forza gravata da illusioni e da miti rivelatesi catastrofici ma essenzialmente figlia della frattura profonda che si era creata dopo Porta Pia tra il popolo e lo Stato unitario. Il segreto fu quello. Fu che il PCI -resistendo al fascismo in forme eroiche e rileggendo con gli occhi di Gramsci la tormentata storia dell’Italia unita- riuscì più di altri a raccogliere l’ondata di autentica rivolta e al tempo stesso di speranza in un’altra Italia che covava sia nelle masse povere che nella gioventù e che il fascismo poi aveva esasperato. Nasce così quella forza popolare e di massa –il PCI- la quale –non lo dimentico affatto- porta anche pesanti responsabilità per le successive vicende della sinistra italiana. Ma che una cosa rivoluzionò davvero: il vecchio rapporto tra dirigenti e diretti e in molte regioni la cultura civile degli italiani.
La figura di Trentin sta in quel mondo e in quella storia. E’ lì che si realizza quel grande salto (non fu riformista?) che modernizzò l’Italia e pose fine alla dicotomia tra il sovversivismo delle plebi e l’elitismo estetizzante degli intellettuali. E’ questo fenomeno che consentì a personalità straordinarie come Trentin di finalmente esprimersi non più solo come vertici solitari, (a differenza delle generazioni precedenti). E ciò per la ragione che è li che avviene una grande mobilitazione dal basso delle energie popolari mai vista prima così intensa, e l’incontro del popolo con gli intellettuali. E questo perché il terreno dell’incontro è nuovo ed è molto avanzato. Era la costruzione di uno Stato a base di massa, di una Repubblica democratica la cui Costituzione afferma al suo inizio che è “fondata sul lavoro”.
Che strana e clamorosa contraddizione. Da un lato il nome di questo partito si riferiva a una ideologia irrealizzabile e clamorosamente fallita (il comunismo). Dall’altro lato, esso continuava, a suo modo, l’opera che il Risorgimento aveva lasciato incompiuta e si collocava lui (molto più del PSI) nel solco aperto dalla grande predicazione socialista dell’inizio del secolo. Portava le masse escluse nello Stato, le trasformava da povera gente assetata di giustizia ma costretta da secoli a togliersi il cappello davanti al padrone in cittadini. Di più: in costruttori di uno Stato certamente liberal-democratico nella sua forma istituzionale ma con una base nuova costituita da quella che chiamammo la “democrazia che si organizza”. Senza di che non si capisce nemmeno il sindacato, quel sindacato confederale e unitario concepito da Di Vittorio, autonomo dai partiti ma che a differenza del resto d’Europa non si riduce a una somma di corporazioni e di mestieri ma diventa un soggetto politico. Cioè una forza che non esprime solo una coscienza di classe ma che orienta la lotta dei lavoratori secondo una visione dell’interesse generale. Classe e nazione. Questa è la scelta di fondo. Questo è Bruno Trentin.
Io Bruno l’ho conosciuto, quando lavorava all’ufficio studi della CGIL. Vivemmo insieme quella che nel mio ricordo resta come una immensa felicità. Non parlo della giovinezza (anche) ma della felicità di scoprire la politica come la cronaca che si fa storia e diventa vita; la libertà riconquistata, la lotta, il sangue e la vittoria, la scoperta dei compagni e, al tempo stesso, l’Italia come patria bellissima e la conoscenza di capi che venivano da lontano ed erano anche grandi maestri. E poi i libri fino a ieri proibiti, il dibattito delle idee, e, perché no? gli amori, le ragazze. Non eravamo riformisti? Come mi sembrano sterili certe polemiche di oggi. Trentin non aspettò l’arrivo di Tony Blair che, anzi, considerava quasi un nemico. Il suo riformismo, compresa la sua polemica contro il “leninismo” del PCI, il suo amore per una certa sinistra intellettuale francese era una cosa molto diversa. Il vecchio Pio Galli che era il suo braccio destro alla FIOM e che vive da pensionato a Lecco, nella Brianza leghista, ripensa con enorme stupore agli anni in cui con Trentin eravamo riusciti –mi dice- a convincere quegli operai a scioperare e a perdere giornate intere di paga per chiedere al governo che le fabbriche andassero al Sud. Incredibile. Oggi sembra perfino incredibile che il riformismo italiano (quello reale) abbia espresso cose come queste: veri atti di governo della società pur non disponendo di questo esercito di ministri, sottosegretari, sindaci, assessori, governatori di regione.
Trentin fu il vero inventore dei consigli, cioè di un sindacato nuovo che esprimeva direttamente la volontà di tutti i lavoratori scavalcando il diaframma delle commissione interne e delle correnti politico-sindacali. Fu difeso da Lama e io ricordo bene quella drammatica riunione della Direzione del PCI, al termine della quale i conservatori furono battuti. Ma Trentin fu anche l’uomo (e io credo che qui si misura la sua statura intellettuale) che capì che cosa comportava il fatto che la vecchia Italia contadina si trasformava in un paese industriale. Fu lui il più acuto analista delle nuove tendenze del capitalismo italiani e a rendersi conto di quale cambiamento del lavoro ciò comportava. Ed è su questo che si aprì una grande discussione in cui il suo vero interlocutore e in parte antagonista fu Giorgio Amendola. Come si può far finta di non vedere che la storia della CGIL e quella del PCI per lungo tempo si sono intrecciate? Su questa base si creò il legame profondissimo di affetto, oltre che di amicizia politica con Pietro Ingrao, quest’uomo straordinario di cui nessuno parla. Capisco. I tempi sono questi. Ma posso io dire adesso, dopo tanti anni, che le decisioni (naturalmente) le prendeva la CGIL, ma che fu a casa di Ingrao che noi discutemmo cose grosse: come guidare l’autunno caldo, come preparare le conferenze operaie, come organizzare la grande discesa dei metalmeccanici a Reggio Calabria contro le forze fasciste che l’occupavano?
Bruno non era un gregario. Pensava con la sua testa e comandava. E io credo che la sinistra, compresa quella di oggi più che mai alle prese con problemi che riguardano la sua stessa sopravvivenza deve a Trentin moltissimo. Egli fu se non il solo, il più lucido e il più determinato nel porsi il grande interrogativo che ancora ci assilla: se e quale potesse essere il futuro non solo del sindacato ma della sinistra dopo la grande sconfitta che alla fine degli anni ’70 il “lavoro” subì in tutto il mondo. Non si fece illusioni. Capì che cambiava tutto e che la storia del movimento operaio, dei suoi partiti e del sindacato industriale registrava qualcosa di più di una discontinuità: una rottura. Ed era con questo, non solo con Craxi che il riformismo si doveva misurare.
L’amara verità è che la sinistra, colpita nelle sue vecchie certezze, si poneva invece sulla difensiva non comprendendo le straordinarie potenzialità insite nei processi innovativi. Toccò a Trentin, molti anni fa a Chianciano dire alla CGIL che questi processi –di per sé- non erano affatto destinati a rendere il lavoro una merce senza valore; e ciò per il fatto semplice quanto oggettivo, che il lavoratore moderno essendo colui che eroga sempre meno fatica fisica e sempre più sapere e intelligenza, va valorizzato anche come individuo. Certo, non era facile. A parole la nuova destra esaltava il liberismo e l’idea del mercato come legge naturale, ma nei fatti utilizzava il bilancio pubblico e il potere statale per imporre un gigantesco processo di redistribuzione delle risorse per la via di un fisco sempre più ingiusto e di una riduzione della spesa per servizi sociali effettivi. E per instaurare nuove forme di dominio sullo Stato, sulle funzioni pubbliche e anche su tutti quegli strumenti (le istituzioni culturali, i mass-media) che formano le idee, i valori, la coscienza di sé, la visione della realtà, i modi di pensare.
Di Bruno Trentin avremmo oggi un grande bisogno. Perché una riscossa, finalmente, deve essere costruita, ed essa è possibile ma alla condizione di comprendere le nuove contraddizioni che colpiscono non soltanto la parte più debole e sfruttata del monto del lavoro, dal momento che si aprono problemi più vasti di diritti di cittadinanza, di libertà e di affermazione di sé, di svuotamento degli strumento della democrazia e della rappresentanza, di rapporto fra governanti e governati. Questo ci ha detto Bruno. Ci ha insegnato che il lavoro intelligente e informato è, in ultima istanza, la vera ricchezza delle nazioni nell’epoca della globalizzazione.
E’ la sua vera eredità. Fu la sua grande passione. Perciò la sua perdita noi l’abbiamo sentita come una ferita molto profonda.
Alfredo Reichlin